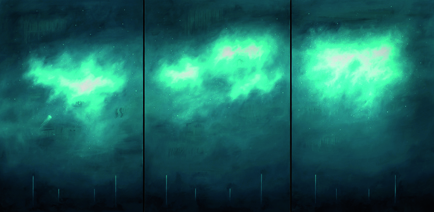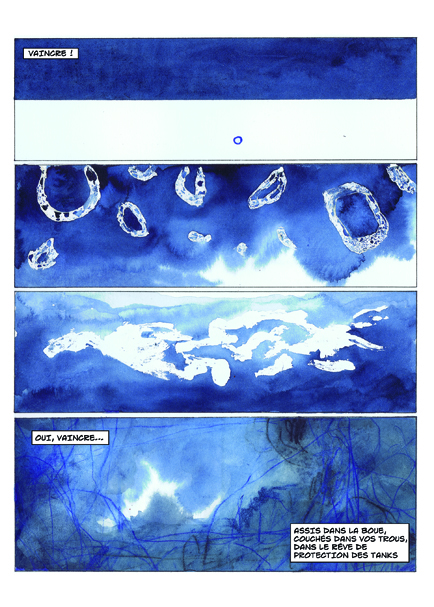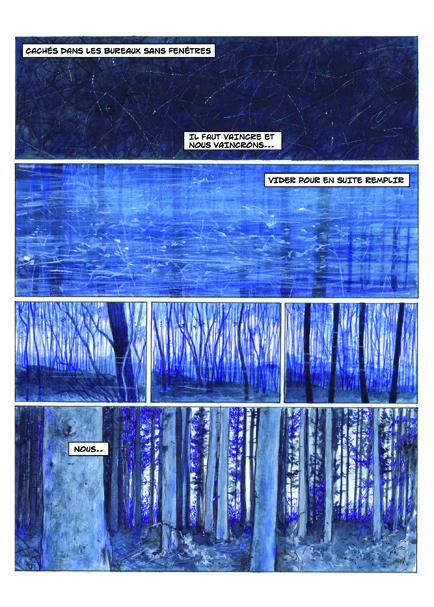paradossi della libertà
_____________________________per leggere l’intero saggio scarica l’ebook 10
#_1
Paradosso contemporaneo della libertà, secondo il modo di vita occidentale: le persone sentono di godere e godono indubitabilmente di una sempre più ampia libertà individuale; sono sempre meno vincolate verso codici etici e regolativi, schemi di comportamento, impostazioni morali o simboliche stringenti, verso obblighi formali/sostanziali nei confronti delle istituzioni; sentono di non dovere più rispondere, come accadeva un tempo, a autorità centrali e sovrane. Si sentono sempre più libere di scegliere a favore del proprio benessere privato, dall’orientamento sessuale alla responsabilità verso l’altro, dai legami affettivi alla affermazione delle proprie passioni. Un mondo liquido, senza legami, senza riferimenti, o senza costrizioni, un mondo “liberato” per l’individuo. Eppure il mondo “liberato” per l’individuo è allo stesso tempo anche un mondo “liberato” dal soggetto, il quale è assorbito quasi completamente dalla condizione di individuo, che a sua volta si identifica sempre più con il proprio involucro, o esoscheletro, di relazioni e prestazioni sociali. Tanto che qualsiasi persona sana di mente si sente sempre più costretta e imprigionata nella mole quotidiana delle richieste sociali: dover essere sempre efficiente e produttivo in ogni momento e ambito della vita (dalla percezione di sé come persona che si afferma, alla conquista di uno status anche lavorativo, dalle performance affettive o sessuali, alla cura di sé); rispondere al dovere di essere in comunicazione in tempo reale (mail telefonate social ecc.); rispondere all’obbligo del godimento perpetuo, in nome di una vita costantemente piena di sensazioni e dove si intensificano le esperienze del mondo (una vita non basta a conoscere il mondo, bisogna viverne varie, accelerare tutti i tempi); rispondere all’obbligo di una costante valutazione del proprio passaggio nel mondo, a costo di non rimanere indietro nel computo economico che a ognuno viene richiesto di fare su se stesso; mettere tutto a valore, doversi sentire in perpetua crescita, e quindi espandere sempre i propri territori o domini; sentirsi obbligati a rispondere alle ingiunzioni della burocrazia ipertrofizzata o della tecnologia (che gareggiano l’una con l’altra). Sentirsi in definitiva sempre più risucchiati dal principio della competitività (essere sempre sul mercato, come persone e come individui) e costretti all’interno di un meccanismo (la ruota del criceto) che richiede prestazioni a ciclo continuo in favore della libertà di scelta personale, ma a discapito tanto della condivisione collettiva, e quindi della partecipazione politica, quanto della possibilità di esistere come soggetto portatore di desiderio. Da qui la domanda:
Questa libertà rende liberi?
Questa libertà rende felici?
Questa libertà lascia uno spazio reale a un’ipotetica autorealizzazione di sé, se non alla conquista dell’autonomia e dell’emancipazione?
Questa libertà prevede ancora la presenza dell’essere umano, nelle sue caratteristiche specie specifiche, e cioè privo di uno scopo determinato, aperto alla contingenza illimitata, e quindi alla continua ricerca di senso, o fabbrica un individuo già disegnato dentro format che di questa libertà permettono la riproduzione?
#_2
Se pure la nostra modernità contemporanea (liberale, democratica, scientifica, tecnologica, impegnata per i diritti civili ecc.) ha nel nucleo fondamentale del proprio progetto il concetto stesso di libertà, quale principio inderogabile e bene universale intangibile, e sa di averlo ricevuto come principale eredità della rivoluzione francese (che lo espresse nella sintesi del celeberrimo motto “liberté, egalité, fraternité” – obiettivo illuministico complessivo da perseguire verso l’emancipazione di persone, individui e popoli), questa stessa eredità tuttavia nel corso del ventesimo secolo si è gradualmente dissipata; tanto che adesso si lascia conoscere ogni giorno nella sua versione mutilata, che può riassumersi nel nuovo motto: “liberté egalité fraternité”. Dove “egalité” e “fraternité” continuano a rimanere sullo sfondo, come idea astratta, obiettivo ideale perseguito dalle persone di buona volontà e dalle istituzioni che si definiscono “democratiche”, ma che in realtà è un obiettivo caduto in oblio, finito in una «morta gora» del fare e del sentire, a seguito della graduale eclissi della politica quale motore del mondo e delle coscienze a favore dell’economia trionfante e delle sue logiche. In termini politici e sostanziali è dunque decisivo mettere a fuoco cosa e chi coinvolge la retorica e la pratica attuale della libertà: non le comunità; non i gruppi; non le minoranze; non i territori; ma solamente alcuni individui in termini ideali; le merci e il denaro astratto in termini reali; i corpi o le persone in quanto oggetti economici e/o merci (forza lavoro; consumatori; target commerciali) in termini reali.
Chi allora oggi può dirsi libero?
E soprattutto, se questa libertà non è fraterna e non è uguale e quindi non è, di fatto, un principio estendibile all’intero globo, chi e quanti sono quelli che hanno, o hanno avuto, diritto alla libertà?
Chi oggi non è uguale?
Chi oggi non è fratello, compagno, umano?
Insomma, chi oggi non è libero?
#_3
La libertà degli individui (e dei beni), tanto nella percezione comune che nella teoria politica ed economica, è una condizione tanto importante e irrinunciabile, che dove è assente occorre esportarla (insieme alla democrazia) con la forza delle le armi; senza che di questo sia percepito, neppure ironicamente, il paradosso. Paradosso che in molti momenti della storia moderna il capitalismo ha ora celebrato ora nascosto, ma che non ha mai negato. Attualmente il neoliberalismo, che della libertà e del capitalismo ha declinato le sue versioni, si è inverato addirittura come qualcosa di più di un’idea regolatrice o di un’ideologia divenuta egemone: piuttosto una forma di vita che, sebbene spesso fallimentare sul proprio piano d’azione, l’economia, si è affermata come nuova mentalità e nuovo sensorio – una nuova antropologia – sostituendosi a quasi tutte le forme di vita sociale e psichica che l’hanno preceduta. La messa a valore di ogni cosa, compresa la vita stessa; la coazione al calcolo economico come principio assoluto; la competizione e la concorrenzialità come metro di relazione tra le persone, le comunità, gli stati; la subordinazione delle decisioni politiche a una presunta libertà di scelta individuale; la spinta costante alla crescita personale, pena un sentimento di inadeguatezza e sconfitta. Questo è divenuto il modo di vivere di miliardi di persone nel mondo, eppure è una condizione pesantissima sul piano della felicità sociale, oltre di quella individuale, schiacciata sotto il peso delle passioni tristi, e della cosiddetta nuova clinica psicoanalitica: ansia, depressione, anoressia, bulimia, attacchi di panico ecc. Incredibilmente questa macchina sociale, dominata dal suo algoritmo di valore, che deve mantenere la vita stessa all’interno delle dinamiche di mercato, alla fine non differisce dalla vita sociale nel suo insieme, nel senso che alla fine la modella a sua immagine (l’uomo unidimensionale dell’antropologia neoliberale ha perso la capacità di confrontarsi tanto con il fuori di sé, quanto con il proprio inconscio). Si fa sempre più evidente che amministrare la distribuzione di ciò che è desiderabile (e quindi dominare attraverso le passioni, invece che attraverso la coercizione) è forse l’effetto più evidente del nuovo dominio totalizzante ma invisibile del capitalismo della nostra epoca (e della sua natura di classe): dominio affidato a una nuova divinità, l’algoritmo del valore che regola senza difficoltà tanto l’immaginario della potenza, che quello dell’impotenza. La natura arbitraria del mondo sociale non è mai stata così pacificamente inoculata come natura necessaria, come dato di fatto, come immagine diretta del mondo.
Alla fine dunque scegliamo liberamente di essere liberi?
Sappiamo cosa comporta essere liberi in questo modo?
Sappiamo a chi si rivolge, chi libera e chi domina questa libertà?
E poi qualcuno è libero dal dover essere produttivo?
Dall’obbligo di consumare?
Non è forse questa esistenza libera e liberata una delle forme di vita più totalitarie che si siano mai immaginate?
Non era forse il potere sovrano un gradino sotto a questo congegno o algoritmo che fa di tutto per chiudere gli spazi alla possibilità non solo di modificare il mondo, ma anche di essere, o essere nel mondo?
#_4
Come si coniughi per l’individuo occidentale il godimento del massimo delle libertà (con tutti i suoi corollari di libera scelta, autonomia da un potere sovrano, emancipazione dai bisogni, accesso al benessere) al sentimento di vivere in un congegno sociale di cui non si conoscono i meccanismi e sul cui funzionamento non si può intervenire, tantomeno modificare, e in cui, al massimo del conformismo, ognuno può scegliere, o meglio desiderare, di essere esattamente allineato all’algoritmo della normalità (una nuova forma di totalitarismo di fatto), è anche questo un paradosso che, questa volta sì ironicamente (se non fosse per la sofferenza psichica e sociale che comporta), resta velato alla percezione comune. In questa dimensione totalitaria, a differenza del totalitarismo classico regolato da un potere sovrano, non rimane tendenzialmente alcuno spazio vuoto: vale a dire che rimane sempre meno spazio (e meno tempo) all’impensato, al desiderio, alla speranza, all’utopia. L’infelice espressione “tempo libero” dà l’idea di come siano stati sistematicamente saturati gli spazi che un tempo rimanevano vuoti insieme alle anomalie del desiderio: le industrie del turismo e dell’intrattenimento di massa, senza parlare dei mezzi di comunicazione commerciali, danno l’idea di come anche il vuoto esistenziale, non solo il tempo libero dal lavoro, è stato brillantemente messo a valore. Il tempo dell’inoperosità e dell’improduttività, il tempo che gli antichi chiamavano ozio, è stato cancellato dall’orizzonte di vita legittimo e esente da colpe; tanto che questo tempo inoperoso si trasforma o in noia (riflesso anche della sempre più tipica identificazione di sé nel lavoro) o nella coazione a riempire quel tempo potenzialmente vuoto di esperienze sempre nuove (viaggi, concerti, spettacoli, degustazioni ecc.), ma che raramente sono esperienze, si sarebbe detto un tempo, autentiche. La noia come negazione e la coazione all’esperienza sono d’altro canto le due facce della stessa medaglia: nel nostro mondo non c’è spazio per ciò che non crea valore. La figura dell’imprenditore integrale, l’imprenditore di se stesso, rappresenta bene il tipo antropologico di questo mondo, dove la libertà di mettere e di mettersi a valore diviene la natura dentro la quale individui e persone si muovono senza nemmeno saperlo.
Ma alla fine, nell’intimità quotidiana, ci accorgiamo, siamo consapevoli, al di là della retorica razionale, di essere liberi?
O piuttosto ci lasciamo trasportare dolcemente dal flusso dell’algoritmo della libertà?
O piuttosto ancora la condizione di libertà si è fatta opaca, ha smesso di essere un’opzione?
E allora quanto a lungo saremo disposti a tollerare di essere liberi?
E quanto a lungo ci sentiremo liberi in un mondo totalitario e totalizzante?
E, ancora più urgentemente, ci sono o ci saranno alternative al dominio dell’uomo libero?
_____________________________per leggere l’intero testoscarica l’ebook 09